Parla la volontaria del 143: «Sempre più soli e sofferenti»

Da 50 anni si mettono a disposizione di chi ha bisogno di essere ascoltato per scaricare problemi e ansie.
N. alza quella cornetta da oltre un decennio: «Migliaia di chiamate. E a volte, capita di portarsele a casa, anche se non si dovrebbe».
LUGANO - Da 50 anni sono a disposizione di chi ha bisogno di un colloquio con qualcuno per scaricare ansie, stress, parlare dei propri problemi e delle proprie angosce. Sono i volontari del 143, il Telefono Amico. Sono, persone che, quotidianamente, si mettono a disposizione offrendo un aiuto mediante l’ascolto. In occasione del mezzo secolo di attività di questa associazione, abbiamo voluto ascoltare noi una di queste voci, quella di N.*, attiva nella rete del 143 da oltre un decennio.
Da quant’è che è volontaria per il 143 e come si è avvicinata al telefono amico?
«Sono circa 12 anni. Mi sono avvicinata al Telefono Amico spinta dal desiderio di fare qualcosa di utile per la società. Ho seguito le mie inclinazioni ritenendo che questa potesse essere la soluzione a me più consona».
C’è stata, suppongo, una preparazione precedente alla prima telefonata
«Ho seguito una formazione, che è poi quella di tutti i turnisti. Consta in diversi incontri distribuiti su un arco temporale di nove mesi. Si segue una preparazione precisa, con basi di psicologia, utile per capire l’altro, ma anche sé stessi. Questa formazione spesso ha un effetto chiarificatore anche per noi volontari, prima ancora che per le persone a cui daremo poi ascolto».
Se la ricorda la prima chiamata post formazione?
«Proprio la prima chiamata no. Ma ricordo il mio stato d’animo durante quel momento. Ero molto emozionata; in parte sapevo cosa stava per arrivare, ma ero lì da sola, senza nessuno ad accompagnarmi. Mi sono messa in ascolto della persona che con fiducia si apriva a me, provando un forte senso di rispetto».
In tutti questi anni, quante chiamate avrà ricevuto?
«In un turno di 4 ore se ne possono ricevere da 2, ma è abbastanza raro, a una decina. Dipende poi anche dall’orario, i turni serali sono più frequentati. Penso, senza sbagliarmi, che saranno nell’ordine di qualche migliaio».
Ad affrontare tutte queste storie non c’è il rischio di portarsele anche a casa?
«Forse all’inizio, ma è una cosa che è meglio non fare. La scrivania con il telefono è una zona protetta e lì dobbiamo lasciare tutto, quando l’abbandoniamo. Alla fine viene abbastanza automatico. Durante la formazione ci è stato spiegato che questo è il modo migliore: non fare proprie le emozioni degli altri per essere in grado di aiutarli. Anche con le chiamate più aggressive, bisogna imparare a non cedere all’impulso di rispondere per le rime».
Capita di dover contattare le autorità, magari in situazioni limite?
«A me non è mai successo, ma può capitare di dover fare intervenire i soccorsi. Di solito non siamo noi che chiamiamo, ma stimoliamo la persona che ci contatta a farlo».
Qual è lo stato di salute della società ticinese e com'è cambiata in questi anni?
«Nel corso di un decennio qualcosa è cambiato. L’impressione è che sia aumentata molto la solitudine. E con essa, forse anche di conseguenza, i problemi psicologici o addirittura psichici. Naturalmente la pandemia prima, e una guerra ora, hanno contribuito ad aumentare queste sofferenze. Abbiamo ricevuto tantissime telefonate di persone terrorizzate dal Covid. Adesso c’è la guerra in Ucraina e siamo punto e daccapo».
C’è una storia che l’ha colpita più di altre, che le è rimasta impressa?
«Le storie che scuotono di più sono quelle che ci mettono nella condizione di dover chiamare un soccorso. Quindi suicidi, violenze domestiche o vicende che vedono protagonisti dei giovani. Quando chiama un giovane che è in difficoltà e, magari, non ha più voglia di vivere, ecco... Quelli sono racconti che si tende a portarsi dietro un po’ più a lungo. Sono il nostro futuro, si cerca davvero di aiutarli, prima di tutto ascoltandoli. Alla fine, la base del nostro lavoro è proprio l’ascolto. E oggi si ha la tendenza a sentire, ma non ad ascoltare davvero».
Immagino che, a volte, dall’altro lato del telefono ci sia qualcuno che non parla. C’è una parola chiave per far iniziare la conversazione?
«Succede anche che riappendano. Molto spesso si comincia con un semplice “come va?”. Se c’è una persona che è in preda al pianto le si dà tutto il tempo, lasciandola sfogare, ma facendo sentire la nostra presenza. Si lascia fluire l’emozione aspettando che arrivino le parole. Alla fine sono più rilassate e ringraziano. Per chi chiama può essere utile togliersi un peso dalle spalle anche se solo per un momento. Anche se il problema non sarà risolto, parlarne e raffigurarselo aiuta a volte a dargli una dimensione e un peso diversi».
Nel vostro lavoro contano molte le parole. Le parole giuste. Cosa non bisogna mai dire invece?
«Le parole sono fondamentali e, soprattutto, devono essere poche. È l’ascolto che conta in questi casi. È l’altro che parla. Le parole devono confermare che stiamo attenti, che capiamo il dolore e la preoccupazione di chi chiama, ma soprattutto devono confermare che non stiamo minimizzando o giudicando. Le parole da non dire, quindi, sono: “Lei non deve”, “Lei ha sbagliato”, “Guardi che non è grave”. “Lei deve”, “Io farei”. Ognuno ha il suo modo di percepire i problemi e quindi anche di affrontarli. Sminuire è un po’ mettere una distanza, allontanare la persona che ci sta chiedendo un aiuto».
Siete un po' come eroi dei fumetti, salvatori senza un volto. Quanto conta per voi mantenere l'anonimato in questo lavoro? E perché?
«È un’immagine che mi fa sorridere e mi inorgoglisce, in un certo qual modo. Più che salvare, noi cerchiamo di aiutare. L’anonimato è fondamentale perché permette a chi chiama di trovare una libertà di espressione che aiuta ad aprirsi completamente, magari proprio perché ha davanti una persona che non conosce e che non sa chi è che parla».
*nome noto alla redazione.























































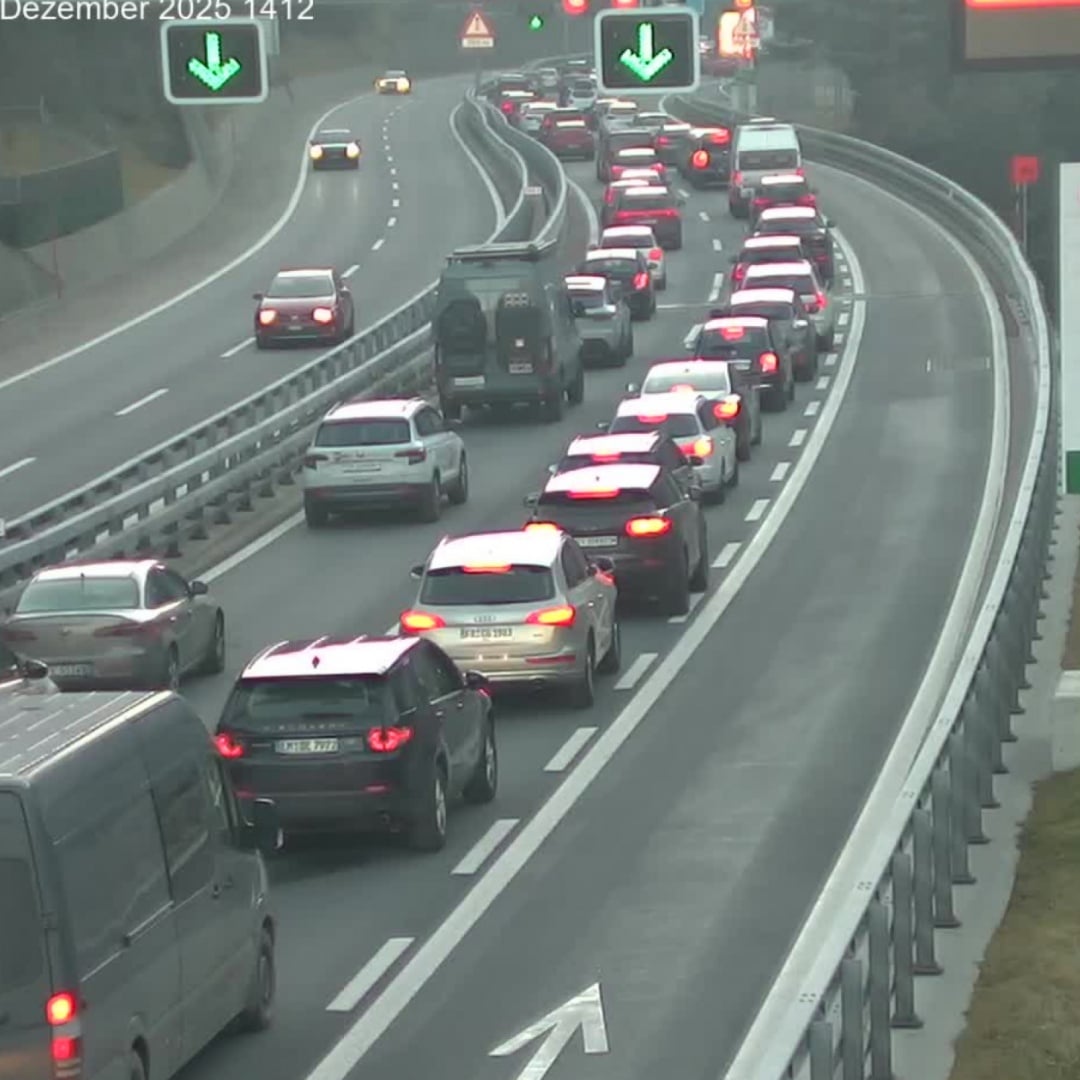





Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!