«Covid, chi ha osato cercare altre chiavi di lettura è stato accusato di irresponsabilità»

Il reporter Gianluca Grossi crea scompiglio in libreria con la pubblicazione di "La libertà è una parola". Ecco perché.
«Da subito abbiamo reagito consegnando la pandemia alla categoria dei fatti impensabili. Abbiamo smarrito il senso della Storia. È mancato uno spazio per riflettere su posizioni diverse».
LUGANO - Una critica esplicita a come istituzioni e media hanno affrontato la pandemia. «Nel nome della paura». Sta facendo discutere il tour nelle librerie del reporter di guerra Gianluca Grossi, autore di "La libertà è una parola. Sul giornalismo apocalittico" (Redea Publishing). Il noto giornalista bellinzonese non usa giri di parole. «Il mio scopo non è fare la predica ai colleghi – precisa –. Anzi. Le mie sono riflessioni su scala globale».
Nel testo lei puntualizza subito di essere ipocondriaco e di avere preso sempre il Covid sul serio.
«Vero. Metto le carte in tavola con una buona dose di autoironia. Fornisco inoltre l'autocertificazione di avere preso sul serio la pandemia, dall'inizio. Provo rispetto e partecipazione per il dolore di chi ha perso una persona cara o si è ammalato gravemente».
Dunque?
«Il mio libro si concentra sul racconto della realtà pandemica prodotto dai mezzi di informazione. Cerco i motivi per i quali la riflessione e la discussione portate avanti dal ragionamento non hanno trovato spazio. Si è invece ricorso a una divisione artificiale tra "responsabili" e "irresponsabili". In mezzo non veniva tollerato più nessuno. La vittima illustre di questo sottile ricatto è stata proprio la ragione».
Secondo lei i media hanno seguito questa onda?
«L'hanno ufficializzata, in generale direi proprio di sì. Hanno consegnato il virus alla categoria dei fatti impensabili, per non dire impossibili. In realtà, si tratta soltanto di una delle tante cose che la vita è capace di farci. Hanno così coltivato il senso di minaccia universale potenziato dal fatto che, per la prima volta, tutto il mondo ha reagito nello stesso modo: fermandosi. Si è fermato anche il nostro pensiero: chi ha osato ricorrervi è stato accusato di mettere in pericolo la vita altrui».
All'inizio però era davvero un fenomeno nuovo per tutti.
«Nuovo, non impensabile. Abbiamo affrontato la pandemia come se fosse una minaccia estranea al nostro stare al mondo. Per descriverla, i mezzi di informazione non hanno quindi potuto fare altro che ricorrere a un registro e a un linguaggio che rispecchiasse il senso di questa minacciosa eccezionalità. È ciò che nel libro definisco giornalismo apocalittico».
Che spiegazioni si è dato?
«Abbiamo perso il senso della Storia. Coltiviamo la certezza di vivere in una società a tal punto progredita da consentirci di neutralizzare sul nascere qualsiasi minaccia. Dimentichiamo che ogni giorno decine di persone attorno a noi tornano a casa con diagnosi terribili. Viviamo in un'era in cui riteniamo che alcune cose non possano più verificarsi collettivamente. Ecco perché la pandemia ci ha sorpresi».
Ci si è illusi che il progresso potesse renderci invincibili e inattaccabili?
«Possibile. Senza dubbio pensiamo che essendo tanto evoluti tecnologicamente, siamo meno fragili. Ecco il problema. A disorientarci e a farci soffrire è stata la scoperta della nostra fragilità. Non c'erano extraterrestri ostili che ci stavano attaccando. Accadeva semplicemente qualcosa che fa parte della vita».
Personalmente come ha vissuto i primi mesi di pandemia?
«Nelle prime settimane, da ipocondriaco. Fino al momento in cui ho capito che qualcuno stava cercando di mettermi paura. Ho reagito, ricorrendo al pensiero, alla ragione. La paura stava diventando un linguaggio. Bastava ascoltare la comunicazione dei governanti, dei sanitari, dei mezzi di informazione. Il registro apocalittico era ormai diventato predominante. Non parlo solo della Svizzera. Ho osservato il racconto mediatico di vari Paesi. Il registro era lo stesso. Era quasi impossibile trovare testate che avessero il coraggio di scollarsi dalla versione ufficiale della realtà. Abbiamo avuto due anni di tempo per correggerci. Non lo abbiamo fatto. Così, gli automatismi mediatici consolidatisi nella pandemia si ripresentano nel racconto della guerra tra Russia e Ucraina».
Perché?
«Ho l'impressione che si racconti la guerra per la prima volta, che si racconti la prima guerra in assoluto. Alla Storia è riuscita anche questa sorpresa soltanto perché eravamo distratti. Due anni di racconto mediatico della pandemia hanno sostituito le categorie dei buoni e dei cattivi con quelle dei sani e dei malati che ritroviamo in questa guerra: ci viene raccontata come la conseguenza di una mente impazzita. Chi lo mette in dubbio viene definito schierato dalla parte sbagliata. Ciò non aiuta a capire, al contrario. Questa guerra, come tutte le guerre, ha delle radici: affondano nel passato, un passato recente. Non soltanto ribolliva da otto anni, ma le avvisaglie c'erano state molto prima, a più riprese. Provo avversione per la guerra, ne ho viste tante da vicino: la provo perché tutte si sarebbero potute evitare».
Lei critica la stampa. Però, anche a causa dell'aggressività sui social, non è stato facile reggere l'urto pandemico nemmeno per i giornalisti.
«I social quasi sempre si prendono colpe e responsabilità di cui non sono all'altezza. Il mio libro non è una predica calata dall'alto. È una dichiarazione d'amore per il giornalismo. Detto questo, è innegabile che quest'ultimo abbia contribuito a diffondere un senso di minaccia costante, a prediligere la sottomissione del pensiero alla versione ufficiale della realtà piuttosto che il pensiero critico. È mancata la difesa della terra di mezzo, che è un luogo indispensabile in cui potere riflettere in modo razionale occupando posizioni diverse, senza per questo essere consegnati al girone dei complottisti, oppure a quello degli asserviti al potere. È questo lo spazio che i mezzi di informazione dovevano difendere».
























































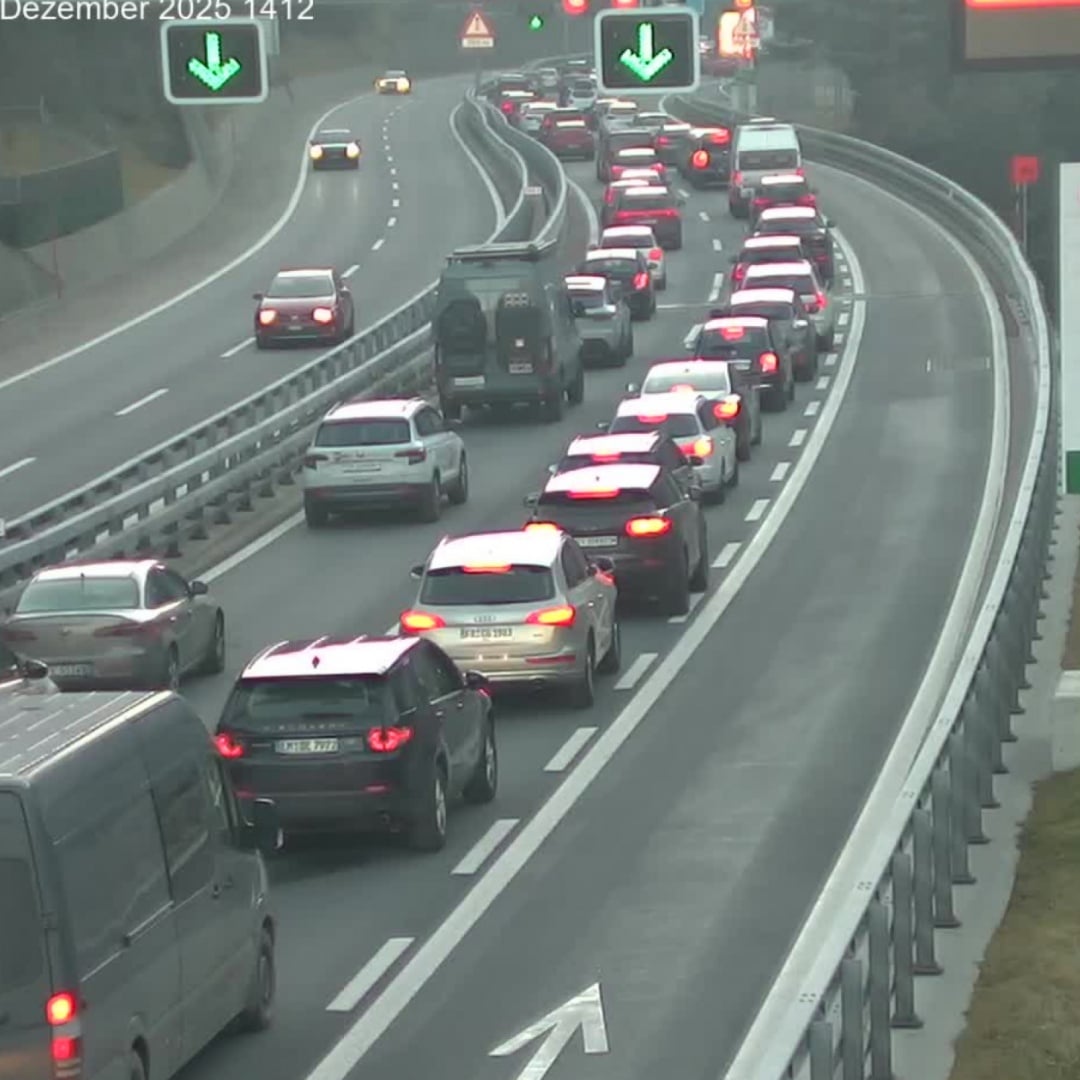





Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!